Vaccini: favorevole senza riserve a molti, dubbioso su alcuni, perplesso sull’applicabilità della Legge 119
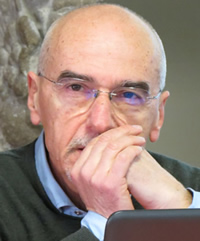
Virgilio Meschi
Mi pare di averlo fatto con senso critico e di non essermi fatto influenzare da pregiudizi di sorta, anche nei confronti di vaccini allora non obbligatori.
Ho cambiato idea in più occasioni nel merito di alcune vaccinazioni, per adeguarmi a ciò che in quel momento risultava essere lo stato delle evidenze scientifiche.
Ho anche effettuato personalmente centinaia di vaccinazioni.
Non credo di essere stato irretito, consciamente o meno, in complotti varia natura.
Al contrario ho avuto modo di assistere direttamente o indirettamente ai benefici dei vaccini, vedendo scomparire o diminuire sensibilmente l'incidenza di patologie quali vaiolo, poliomielite, difterite, pertosse, morbillo.
Alcune delle quali non ho mai incontrato nel mio percorso professionale, se non sui testi o durante le lezioni universitarie, perché scomparse dal nostro paese prima che io diventassi medico, altre invece da me affrontate nella prima parte della pratica medica e poi viste quasi scomparire strada facendo.
Rarissime volte ho invece assistito direttamente bambini con complicanze vaccinali gravi, mai ho visto decessi attribuibili a tali eventi.
Sento quindi il dovere di intervenire nel dibattito che sta ora dividendo la nostra società su questo tema, pur avendo la consapevolezza che in generale non sono l'esperienza di un singolo, né il parere di un esperto ad avere grande valore nelle decisioni mediche, se queste non tengono conto da un lato delle evidenze di efficacia e, dall'altro, delle circostanze e delle preferenze del paziente nel momento in cui queste devono essere assunte.
Ritengo dunque che, nell'attuale "momento critico" per i vaccini, sia più che mai importante per tutti (politici, tecnici, media e genitori) dominare l'emotività e vincere la pigrizia della superficialità prima di addentrarsi in questo argomento complesso e difficile, in cui è doveroso distinguere tra vaccino e vaccino e tra le diverse malattie che questi si propongono di prevenire.
Infatti tra un preparato vaccinale e l'altro le differenze possono essere talmente importanti per composizione, via di somministrazione, efficacia ed effetti collaterali, da non rendere possibile parlare di questi prodotti prescindendo dalle particolarità di ognuno di essi.
Nell'esprimere un giudizio su un vaccino si dovrebbe sempre tenere conto del rapporto costi/benefici, sia per la singola persona che per la collettività, senza omettere di riferirsi al qui ed ora, piuttosto che far riferimento ad epoche o territori diversi da quelli in cui ci troviamo.
D'altro canto anche le malattie infettive sono talmente diverse sul piano epidemiologico e clinico a tal punto che, parlandone in modo generico, senza fare i doverosi distinguo sul contagiosità, modalità di diffusione e meccanismi patogenetici, si può correre il rischio di disinformare, soprattutto quando certe affermazioni vengono diffuse da alti livelli istituzionali o dai media.
Il mio contributo alla discussione in atto include però un netto contrasto tra posizione a favore della pratica vaccinale e quella invece critica sull'obbligo vaccinale recentemente introdotto dalla legge 119 del 31 luglio 2017 (ex decreto cosiddetto Lorenzin), ritenendolo ingiusto, sproporzionato e non utile alle finalità che gli estensori della norma si propongono di raggiungere.
Cercherò di indicarne le motivazioni.
La prima è di tipo etico. Infatti, con unica eccezione per il cosiddetto TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) - sul quale forse sarebbero doverosi qualche ripensamento e qualche misura correttiva, ma del quale non intendo però parlarne in questa occasione, né ritengo di possedere i titoli necessari per farlo - nessun trattamento medico e nessuna procedura diagnostica possono essere imposti senza il consenso della persona interessata.
Credo che ormai quasi più nessuno abbia grosse perplessità nel ritenere la libertà di questa scelta un diritto fondamentale della persona. Tanto se ne discute, ad esempio, a proposito dei trattamenti di fine vita e delle DAT (testamento biologico), senza però che si riesca purtroppo a produrre alcuna legge in proposito, contrariamente a ciò che è da tempo avvenuto nella maggior parte dei paesi europei a noi vicini.
Anticipo subito le possibili ed ovvie obiezioni a queste mie affermazioni: la legge in questione interessa principalmente una popolazione di minori e non parliamo di trattamento della patologia di un singolo individuo, ma di una pratica di prevenzione che ha come scopo la salvaguardia di una comunità.
Queste ragionevoli obiezioni aprono questioni di profilo etico e giuridico non nuove ed estremamente complesse, la soluzione delle quali deve essere affrontata nelle sedi previste (servizi sociali e sanitari, tribunale dei minori, giudici tutelari e quant'altro), con la delicatezza e la chiarezza che merita.
Ciò avviene già per altre questioni di carattere sanitario, ma non mi sembra che il legislatore in questa circostanza abbia considerato bene questi aspetti e le possibili conseguenze.
La seconda motivazione, riguarda ancora il legislatore. O meglio la fretta e l'approssimazione con cui il provvedimento è stato calato in un contesto non pronto all'esecuzione dello stesso: il sistema vaccinale e quello scolastico territoriali hanno le risorse umane, economiche ed organizzative per procedere all'immediata applicazione del decreto?
Sembrerebbe di no ed i cittadini se ne sono accorti subito, all'inizio con lunghe ed estenuanti attese a telefoni che non riuscivano a rispondere ed ora ricevendo risposte spesso interlocutorie e talvolta anche contraddittorie.
Le soluzioni che si stanno profilando nell'applicazione pratica del provvedimento appaiono già diverse tra una regione e l'altra, dimostrando, come se ce ne fosse ancora bisogno, che il federalismo nel campo della salute non sempre risponde a criteri di equità e giustizia.
Mi domando il perché di questa fretta, che contrasta con una situazione chiaramente non di emergenza reale, vista l'entità dei casi riportati che, con l'eccezione del morbillo (che appare in aumento nel corso di questa prima parte del 2017), non sembra molto diversa da quella cui abbiamo assistito negli anni passati.
Viene quasi spontaneo pensare che si tratti di una ennesima operazione di facciata in cui la demagogia e la campagna elettorale permanente, con le quali ormai si naviga a vista in questo nostro Paese, abbiano purtroppo un ruolo determinante.
Sgombro subito il campo da un'altra obiezione che mi potrebbe essere rivolta: quella di non considerare la tendenza alla diminuzione, statisticamente dimostrata, dei bambini vaccinati.
Invece la sto considerando e mi preoccupo, ma non credo che i numeri siano tali da destare questo allarme immediato e ritengo che il miglior modo per affrontare questo calo di adesioni sarebbe stato quello di studiare e lanciare una campagna informativa adeguata al problema emergente.
E qui vengo ad una terza questione da non sottovalutare, che è quella che riguarda l'efficacia di un obbligo versus una libera scelta. Libera scelta coadiuvata ovviamente da un'informazione capillare ed autorevole dei cittadini e da una efficace e continua formazione del personale sanitario addetto a questa pratica.
Molti paesi occidentali (ed alcune regioni italiane), in cui non esiste l'obbligo vaccinale, hanno infatti tassi di adesione superiori ad altri nazioni o regioni in cui tale obbligo sussiste.
Purtroppo abbiamo dovuto constatare che, sia sul piano dei contenuti che su quello formale, questi tentativi di informare sono stati spesso mal condotti, con la possibilità concreta di un risultato addirittura controproducente.
Abbiamo infatti visto ed ascoltato sovente persone competenti dal punto di vista scientifico, ma poco abili nella comunicazione ed altre volte bravi comunicatori, ma non altrettanto dotati delle sufficienti conoscenze tecnico-scientifiche.
Tutto ciò ha alimentato una specie di tifo calcistico tra le posizioni ideologiche per l'una o l'altra parte in contesa, senza invece riuscire ad aiutare a perfezionare la conoscenza di tutte quelle questioni in causa, alcune delle quali facilmente illustrabili altre invece assai più complesse od incerte, per le quali sarebbe oltretutto onesto e ragionevole riconoscerne l'incompleta conoscenza.
Se riconosciuti ed affermati addetti ai lavori danno dell'ignorante o del criminale ai genitori che, a torto o a ragione, non intendono vaccinare i propri figli, difficilmente potranno essere convincenti nei loro confronti.
I genitori a loro volta dovrebbero fare il massimo sforzo per cercare di distinguere tra le fonti di informazione credibili e quelle che sposano le teorie complottistiche di varia natura e/o che fondano le loro "verità" solo su aneddoti e non, come sarebbe opportuno, su di un confronto serio che utilizzi l'enorme casistica disponibile in modo quasi ubiquitario e che la letteratura scientifica e gli organismi sanitari internazionali mettono a disposizione.
Ma purtroppo l'utilizzo dell'insulto e della denigrazione degli "avversari", anziché la confutazione pacata e motivata delle tesi altrui, tende ormai a diventare prassi in quasi tutte le piccole o grandi questioni sociali.
Anche su questo argomento, nei "social" e nei dibattiti pubblici, abbiamo modo di osservare quotidianamente come "like" ed applausi siano di intensità direttamente proporzionali non alla consistenza delle argomentazioni, quanto alla potenza dell'insulto o dell'offesa, spesso protetti dall'anonimato facile.
Capita anche qualche volta che figure istituzionali, a vari livelli, cadano in incidenti comunicativi gravi, soprattutto considerando la fonte e il contesto, rendendosi responsabili di un comportamento che provoca discredito e scarsa credibilità nei confronti dell'istituzione che in quel momento rappresentano.
Succede anche che operatori diversi della stesso servizio pubblico diano risposte contraddittorie agli utenti, determinando purtroppo sconcerto e sfiducia da parte di questi ultimi.
Ed ancora, se gli operatori sanitari sono notoriamente poco propensi a farsi vaccinare, con quale credibilità possono costituire un elemento positivo in una campagna vaccinale?
E perché, con le stesse logiche che hanno ispirato la legge in questione, non è allora stato imposto l'obbligo di vaccinazione ad adulti insegnanti ed operatori socio-sanitari?
Lavorare su queste criticità è lavoro lungo, faticoso e poco appariscente. Molto più facile è far demagogia ed promulgare una legge/manifesto, sulla cui difficoltà di applicazione pratica e sulla cui efficacia non si può che essere razionalmente pessimisti.
Mi chiedo inoltre come si possa definire un provvedimento legislativo che impedisce a bambini non vaccinati di frequentare asili nido e scuole d'infanzia, ma consente in pratica ai minori trai i 6 e i 16 anni di frequentare le scuole elementari e medie (salvo sanzione pecuniaria), fingendo così, in maniera ipocrita e furbesca, di non ledere il diritto allo studio?
Per concludere, nella consapevolezza di aver solo sfiorato un tema così difficile e complesso anche per chi lo pratica quotidianamente per professione, riassumo sinteticamente e ribadisco la mia posizione: favorevole senza riserve all'utilizzazione della maggior parte dei vaccini attualmente proposti dal SSN, qualche dubbio e qualche riserva nei confronti di alcuni di essi, decisamente perplessa invece nei confronti della legge 31 luglio 2017, n. 119, ritenendo che essa sia di difficile applicazione, probabilmente di scarsa efficacia e viziata dalla possibilità di introdurre conflitti tra due diritti egualmente importanti quali sono salute ed educazione.
Ringraziando per l'attenzione e con la speranza che queste mie riflessioni possano contribuire ad un dibattito pacato e costruttivo, mi scuso con redazione e lettori per non essere riuscito a sintetizzare maggiormente il contenuto del mio scritto.
Virgilio Meschi















