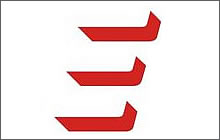Il min. Giuli e la pernacchia vecchia dell'infosfera

Da giorni sta suscitando ilarità la comunicazione delle linee programmatiche fatta lo scorso 9 ottobre da Alessando Giuli, neoministro alla Cultura, quella dei passaggi sull’«ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell’infosfera globale» e sull’epoca «delle passioni tristi».
Chi lo sbeffeggia cita le supercazzole di “Amici miei” (così su Repubblica, la Stampa, e Il Fatto Quotidiano. La7 si è limitata a un «incomprensibile». Il Corriere della Sera e Il Post si sono parati le terga con un neutro «criptico»).
Chi lo difende sostiene che la densità degli argomenti trattati non poteva essere ridotta a parole men che complicate.
«Comincio a leggere una parte un po’ teoretica», ha detto il ministro, prima del vaniloquio ormai diventato virale. Basterebbe questa innocente dichiarazione: chi sa ciò di cui parla non legge. Né fogli scritti da sé, né fogli scritti da altri, come il tono inceppato, lo sguardo indagatore e financo la gestualità vanesia farebbero sospettare sia accaduto.
Chi lo sbeffeggia cita le supercazzole di “Amici miei” (così su Repubblica, la Stampa, e Il Fatto Quotidiano. La7 si è limitata a un «incomprensibile». Il Corriere della Sera e Il Post si sono parati le terga con un neutro «criptico»).
Chi lo difende sostiene che la densità degli argomenti trattati non poteva essere ridotta a parole men che complicate.
«Comincio a leggere una parte un po’ teoretica», ha detto il ministro, prima del vaniloquio ormai diventato virale. Basterebbe questa innocente dichiarazione: chi sa ciò di cui parla non legge. Né fogli scritti da sé, né fogli scritti da altri, come il tono inceppato, lo sguardo indagatore e financo la gestualità vanesia farebbero sospettare sia accaduto.
Io ho letto e leggo molto (non so se più del ministro e della Lipperini: nel caso mi inchino), ma ho capito questo: che chi non sa, o non ha idee proprie, cita.
E cita male, in modo poco astuto, da vecchio. Ci sono parole “marchiate” dal loro tempo, che nascono come brillanti e originali sintesi di una particolare ermeneutica e poi invecchiano, sprecate su cento bocche, infilate in mille discorsi da chi cerca di darsi un tono facendo propri questi concetti forti, e così facendo sbiadisce le tinte forti di questi concetti.
«Infosfera», del filosofo Luciano Floridi, è l’ultima in ordine di apparizione delle parole che hanno costituito una moda culturale.
Ogni settore ha le proprie.
La scuola ha l’aggettivo «inclusivo»: ogni progettazione didattica deve essere inclusiva, ogni strategia educativa deve essere inclusiva, ogni dinamica di classe, di gruppo, ogni gita, cartellone, powerpoint, pagella, tutto deve essere inclusivo, col risultato che nulla è significativo.
La sociologia ha «liquido», dalla fulminante definizione di Bauman delle dinamiche del mondo moderno come quelle di una «società liquida» (era il 1999 quando lo scriveva e siamo ancora fermi lì). Volendo essere più provinciali, la saggistica italiana gode nell’uso dell’aggettivo «generativo». Coniato dalla coppia Magatti-Giaccardi, marito e moglie, sociologi dell’Università Cattolica, starebbe a significare un approccio positivo e fruttuoso alla realtà, capace di cogliere occasioni di sviluppo anche in contesti potenzialmente negativi. E via a scrivere – non dai due, ma da chi li imita – ogni qualvolta bisogna difendere l’indifendibile che «se letto in una prospettiva generativa allora…».
La tecnologia dell’informazione aveva il binomio «apocalittici e integrati», dal futuristico saggio di Umberto Eco del 1964. Sessant’anni prima dell’«apocalittismo difensivo» del futuro laureato ministro Giuli.
La sociologia delle religioni e l’antropologia parla da ormai quasi un secolo di «umanesimo integrale», (il libro omonimo di Jacques Maritain, è del 1936).
La psicologia e la psichiatria parlano di «passioni tristi» da almeno dieci anni (il libro di Benasayag e Schmit è del 2013).
Posso continuare, volendo.
Il problema, allora, non è l’atteggiamento vanesio del neoministro – ognuno ha il proprio carattere e s’ei piace, ei lice – e nemmeno la ricerca di una forbitezza d’eloquio (leggendo, però). È la vecchiaia delle sue idee.
Ministro, mi ascolti: lei è del ’75 come me. Ognuno porta i propri anni come vuole e come riesce. Ma ci sono idee che si possono portare meglio.
Stefano Motta