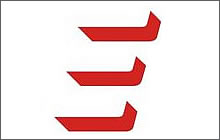In morte di Cesare Maestri

Cesare Maestri
Era già un grandissimo quando nel gennaio del 1959 tentò la scalata al Grido di Pietra, la montagna più difficile del mondo, quell’ago sottile che sfida il cielo tra le vette edeniche della Patagonia, ricoperto da ghiaccio infido e sovrastato da un fungo sommitale di neve, portata dal vento oceanico, così bello a vederlo dal basso, come una nuvola di zucchero filato, così bastardo da arrampicarci sopra.
Nel suo palmares aveva la Nord della Ovest e della Grande di Lavaredo, il Gran Capucin, il Campanile Basso, l’Aiguille du Midi e il pilastro del Dru: nomi da far tremare i polsi. E li ridiscende pure, naturalmente. Non solo perché, come amava dire lui, “l’alpinista migliore è quello che diventa vecchio”, e come tutti sappiamo la scalata non finisce in cima, ma quando ti togli gli scarponi sulla terraferma, diciamo così. No: perché Cesare Maestri amava arrampicare e disarrampicare, aveva il talento dell’incosciente che scendeva come un ragnetto, non calandosi in corda doppia ma procedendo a ritroso.
Da giovane ho provato ad attaccare in salita la via sulla parete della Roda di Vael che lui ha percorso in discesa: non ce l’ho fatta. Si dirà che io ero e sono un alpinista della domenica, e questo è vero. Si dica che Maestri era un genio. Punto.
Quando nell’estate australe del ’59 attacca il Cerro Torre Cesare è già un nome. Lo accompagna Toni Egger, e li coordina dal campo base Cesarino Fava.
Arrivano in cima ma poi, nel traverso in discesa sul nevaio triangolare, una valanga staccatasi dal fungo sommitale aveva trascinato via il povero Egger – i suoi resti vennero trovati nel Natale del ‘74 da una spedizione diretta al Cerro Stanhardt – e la macchina fotografica.
Mentre gli uomini piangono la morte di Egger, le malelingue ironizzano sulla macchina fotografica.
La montagna è un mondo a parte, lo ammetto, dove ci si saluta incontrandosi sul sentiero dandosi del tu, dove si condivide la borraccia e la fatica, ci si spela le dita delle mani e vengono i calli sui piedi per il solo gusto della conquista. Non della cima, ma di sé stessi.
La montagna è il luogo delle persone di parola. I Giuda temono la fatica, e li riconosci dallo sguardo mellifluo e dal sorriso sempre stampato e sempre viscido.
Quando un montanaro ti dice che ha visto un capriolo, ha visto un capriolo. Quando un rifugista ti dice che l’indomani pioverà, pioverà. Quando una guida ti dice che lì la roccia è friabile, fria. Quando un alpinista ti dice che è arrivato in cima, è arrivato.
La montagna non è (non era) di chi se la tira.
Maestri combatté per tutta la vita che gli rimaneva contro il dubbio che non fosse davvero arrivato in cima al Torre. E quando ci riprovò, testardamente, anni dopo, portandosi addirittura un compressore e un martello pneumatico per piantare i chiodi nella roccia, la protesta rabbiosa non era contro la montagna.
Erano al funerale di Armando Aste quando Cesare, alla presenza di Cesarino Fava e di Romano Perego abbracciava Gildo Airoldi, piangendo e singhiozzando: “Ti giuro che ce l’ho fatta”. Forse sono nomi che ai più non dicono niente: cercateli su Google e mettete insieme le cime che questi uomini hanno scalato. Oppure cercateli tra i nostri paesi: Gildo c’è ancora, e mi onora della sua amicizia. E quando io gli ho stretto le mani ho sentito la forza di ogni parete che aveva vinto. No vinto: ricevuto in dono.
Non si può mentire a chi si è spellato le dita come te, perché ti legge negli occhi.
Tra uomini non si mente.
È morto ieri un uomo sincero, di parola.
Stefano Motta