Viaggio in Brianza/14: storia, fauna e flora del Parco di Montevecchia e Valle del Curone

LA NASCITA DEL PARCO
Già alla fine degli anni Sessanta, il territorio di Montevecchia e delle valli circostanti si configurava come un'isola preziosa sfuggita all' urbanizzazione chi aveva investito quasi per intero la Brianza circostante. Il paesaggio singolare ed i caratteri ecologici compresi tra la valle del torrente Curone, Molgoretta e Lavandaia assunsero presto un ruolo importante nelle politiche che miravano a preservare le riserve naturali non ancora divorate dal cemento. L'interesse paesaggistico della zona fu inizialmente sancito dall'apposizione del vincolo per le bellezze naturali con successivi decreti emanati a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta.
Nel 1981 il "gruppo Promotore per la salvaguardia di Montevecchia e della Valle del Curone" presentò una proposta di legge per la costituzione del Parco sostenuto da più di cinquemila firme di cittadini. Nel 1983 la Regione Lombardia pubblicò il volume "Montevecchia e il suo circondario" nel quale riconosceva i risultati di uno studio interdisciplinare che metteva in evidenza le pregevoli prerogative ambientali e naturalistiche di questa preziosa porzione di territorio.
Pochi mesi dopo, il Consiglio regionale lombardo approvò la legge quadro per le aree protette, primo provvedimento del genere in tutta Italia. Nel contesto di questa legge quadro, venne approvata anche l'istituzione del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, affidandone la gestione ad un Consorzio di Comuni. Nel 1986 il Consorzio venne costituito ufficialmente dando inizio al proprio lavoro con la progettazione del Piano Territoriale di Coordinamento e il controllo dei tagli nei boschi. Da quel momento l'atteso parco divenne realtà a tutti gli effetti.
I primi interventi si ebbero nel 1990 e viene inaugurato il Centro Parco presso Ca' Soldato, con cui prende il via l'attività di educazione ambientale e si realizza un primo sistema di sentieri per facilitare la visita dei territori protetti.
Nel 1995 viene acquisita Cascina Butto a Montevecchia, dove si insedia l'amministrazione del Parco. Dal Duemila ad oggi le attività del Parco si sono intensificate: si svolgono azioni di miglioramento forestale e di riassetto e consolidamento di percorsi d'acqua e sentieri, sono state reintrodotte delle specie animali, progettato e realizzato il Centro Visite presso Cascina Butto, recuperati monumenti minori (come lavatoi o edicole di culto), ma soprattutto il parco è divenuto una realtà fruibili e apprezzata da tutti i suoi visitatori.

LA STORIA GEOLOGICA: LA NASCITA DELLE COLLINE
Per comprendere i complessi fenomeni che hanno forgiato il nostro Pianeta, e quindi anche le colline di Montevecchia, bisogna rendersi conto che sono state necessarie decine di milioni di anni, trasformazioni che è possibile riscoprire attraverso lo studio della geologia. Qualcuno ha scritto che le rocce sono le ossa del mondo e le montagne costituiscono il suo scheletro. Infatti le rocce sostengono il terreno e gli danno forma e carattere, tanto che molto dell'essenza di un luogo dipende dalla natura e dalla forma delle rocce su cui poggia.
Per poter riassumere l'origine delle colline di Montevecchia bisogna tornare indietro di ottanta milioni di anni, verso la fine del Cetaceo. A quell'epoca l'area compresa tra il colle di San Genesio e i rilievi di Montevecchia era il fondo di un bacino profondo tra gli ottocento ed i mille metri, molto simile a quello dei mari che tutti conosciamo.
Il materiale che veniva trasportato da torrenti e fiume si andava accumulando: ghiaiette, sabbie, argille impalpabili si depositvano su questo fondale, costituendo quella che viene definita in gergo tecnico "corrente torbida". Questa corrente si ripeté infinite volte per un lunghissimo lasso di tempo, sino a quando forti tempeste o scosse sismiche provocarono lo smottamento del materiale accumulato inizialmente sulle coste, portandolo fino alla piana abissale. Sul fondo si sviluppò il processo di litificazione e i depositi si trasformarono lentamente in roccia per via della forte pressione dell'acqua che sovrastava i fondali.
Mentre nel mare si accumulavano migliaia di strati rocciosi di questo tipo, il continente africano continuava a spingere con forza verso quella che per noi oggi è l'Europa, finendo al di sotto di quest'ultima. Questo processo accelerò significativamente trenta milioni di anni fa, provocando un forte corrugamento in superficie. In questo modo nacquero le Alpi. Il sollevamento della catena alpina ha comportato l'emersione dei materiali rocciosi accumulati su quello che un tempo era il fondo di un bacino marino. Da questo lungo processo di emersione ebbero origine anche i rilievi collinari di Montevecchia e dintorni.
Il Parco ha redatto una carta geologica in cui è illustrata la distribuzione in superficie delle differenti formazioni rocciose e dei depositi superficiali. Da questa è possibile osservare che nel Parco sono presenti due categorie di formazioni, distinte dal punto di visto cronologico e genetico: quella Mesozoico-terziarie e quelle quaternarie.

Da sinistra Giovanni Zardoni (coordinatore GEV) e il presidente del Parco, Marco Molgora
GLI HABITAT DI INTERESSE EUROPEO NEL PARCO DEL CURONE
Nel 1992 l'Unione Europea ha emanato la Direttiva Habitat per la conservazione degli habitat naturali e seminaturale della flora e della fauna di interesse comunitario. Sul territorio dell'Unione sono stati identificati duecento tipi di habitat diversi, le cui caratteristiche distintive possono essere la posizione strategica, ai fini della sosta per le specie migratorie, la presenza di notevole varietà biologica oppure la testimonianza dell'evoluzione dell'ambiente naturale attraverso il tempo. Per quanto concerne animali e vegetali, le medesime ricerche indette ai fini della tutela di questi habitat hanno censito 632 specie, tra cui alcune a rischio di estinzione.
L'obbiettivo finale del provvedimento comunitario è di creare una rete europea di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione Europea stessa, in particolare di una serie di habitat e specie animali e vegetali. Questa rete è stata denominata Rete Natura 2000.
Il Sito di Interesse Comunitario individuato nel Parco ha una superficie di circa milleduecento ettari ed include al suo interno la Valle Santa Croce e l'Alta Valle del Curone, quest'ultima classificata come riserva orientata paesistico-forestale.
Il territorio di queste valli è collinare e si estende lungo le incisioni dei torrenti Curone e Molgoretta. L'elevata diversità ambientale presente si manifesta con tre habitat ritenuti di interesse prioritario: i Prati Magri, le Sorgenti pietrificanti e i Boschi umidi.

I prati magri sono ambienti seminaturali di elevato valore naturalistico data la loro ricchezza in specie vegetali termofile, ovvero che necessitano di temperature miti e che talvolta esprimono condizioni di aridità legate ad un substrato di tipo calcareo. Alla ricca flora in cui appaiono meravigliose orchidee, corrisponde un'altrettanta ricchezza faunistica, soprattutto per quanto riguarda gli insetti (entomofauna), come le farfalle che qui trovano un habitat ottimale.
La conservazione di questi ambienti dipende molto dalle modalità con cui si gestiscono questi ecosistemi. In Lombardia i prati magri sono presenti solo su rilievi calcarei nelle esposizioni più calde, come nella aree a bassa quota nella parte meridionale del Parco del Curone, nella zona del colle di Montevecchia e della Valle Santa Croce nel comune della Valletta Brianza. L'attività agricola su questi terreni è scarsamente conveniente dato che sono poco accessibili a causa della morfologia del terreno (spesso ripida) e la scarsità di acqua; queste difficoltà però non colpiscono i boschi circostanti che, senza una periodica attività di sfalcio, si svilupperebbe anche su questi prati causando la scomparsa delle specie animali e vegetali che le abitano.
Nonostante le difficoltà agricole a cui abbiamo accennato, queste rive sono state terrazzate e intensamente coltivate fino agli anni Cinquanta con vigneti e ortaggi. Le trasformazioni economiche e la necessaria fatica per coltivare hanno spinto i coltivatori ad abbandonare questi terreni, lasciandosi alle spalle anche i nuclei rurali della Galbusera Bianca e Galbusera Nera che oggi hanno ritrovato nuova vita rispettivamente come agriturismo bio e come ristorante.
Nei decenni di abbandono questi terrazzamenti (chiamati ronchi) abbandonati a loro stessi, videro l'ingresso di arbusti prima (come i rovi o il sanguinello) e quindi degli alberi (come il carpino nero ed il ciliegio); le superfici dei prati residui, quelli incolti e le macchie di arbusti e boschi definirono situazioni di transizione fra ambienti diversi, creando le condizioni ideali per alcune specie di uccelli considerate rare e a rischio di scomparsa in Lombardia, come l'Averla piccola e la Sterpazzola.
Nei prati ancora presenti sulle scarpate tra i vigneti, le specie vegetali più diffuse e importanti per la costituzione dell'abitato sono alcune graminacee, ma la specie che più richiama l'attenzione del visitatore sono le orchidee. Con i loro colori delicati o sgargianti colorano i verdi prati magri. Queste distese di verde sono l'habitat privilegiato e talvolta esclusivo per alcune specie di insetti come la mantide religiosa oppure il macaone.

Il Parco si è attivato per tutelare questo ambiente mediante i finanziamenti concessi dall'Unione Europea e dalla Regione Lombardia realizzando indagini approfondite e stipulando convenzioni con i proprietari dei terreni per adottare un modello di gestione dell'attività agricola compatibile con l'habitat protetto. Annualmente svolge interventi per il miglioramento dei sentieri per contenere il transito dei visitatori nel rispetto dell'ambiente che osservano.
L'habitat delle sorgenti pietrificanti è rappresentato da ruscelli, con presenza costante di acqua corrente, in cui avvengono fenomeni di formazione di travertini. Questi ultimi sono delle rocce porose formate dalla precipitazione del carbonato di calcio (comunemente conosciuto come calcare) di cui sono ricche le acque sorgive che lo acquisiscono durante la permeazione dalla superficie nel sottosuolo.
Quando queste acque sgorgano nei piccoli torrenti, tendono a depositare parte del calcare su tutte le superfici con cui vengono a contatto, rivestendo così rocce, foglie ramoscelli e muschi con patine via via più spesso. Questo fenomeno è facilitato dalla presenza di cascatelle e di muschi (precisamente la Palustrella commutata) che, con meccanismi fisici e biologici, accelerano la perdita di anidride carbonica da parte delle acque e facilitano il calcare a depositarsi. Nelle condizioni più favorevoli la formazione di travertini costituisce delle vasche seguite, verso valle, da vere e proprie cascatelle data la "pietrificazione" dei muschi che circondano i ruscelli.

Questi habitat si trovano nel tratto iniziale dei ruscelli, dove si ha una presenza costante di acqua all'interno dei boschi. Il fenomeno di formazione dei travertini diminuisce allontanandosi dalla sorgente, conseguentemente alla precipitazione del calcare, fino a scomparire del tutto dopo alcune centinaia di metri.
Studi effettuati indicano che i fattori più importanti per l'equilibrio di questi ambienti sono la presenza costante dell'acqua, la sua temperatura e qualità; infatti i principali pericoli sono le modifiche delle sorgenti per causa di frane o smottamenti, oppure a per l'intervento dell'uomo. Anche l'inquinamento è deleterio poiché l'aumento di temperatura, come la contaminazione dell'alveo del ruscello, può portare sia alla distruzione dei travertini calcarei, sia all'alterazione dell'habitat.
Per la tutela di questi meravigliosi ruscelli e delle loro microstrutture calcaree, il Parco ha svolto approfondite ricerche scientifiche. Di conseguenza si sono avviati interventi di consolidamento dei versanti, per rendere più stabili questi ambienti e sono state costruite delle passerelle e staccionate per evitare che siano violate le rive dei ruscelli.
L'habitat delle sorgenti pietrificanti può essere osservato in Valle Santa Croce, alle sorgenti del Molgoretta, oppure in Valle del Curone, lungo il sentiero che da Valfredda conduce a Ca' Soldato.

I boschi umidi o igrofili, di ontano nero ed olmo crescono su terreni ricchi d'acqua ove spesso si hanno fenomeni di ristagno. Questi luoghi, come la maggior parte delle zone umide, sono stati nel tempo frequentemente bonificati con l'apertura di fossati o canali di scolo. È raro quindi trovare questi habitat intatti, senza che siano stati intaccati dall'opera dell'uomo.
I boschi di questo genere si osservano normalmente nelle aree periodicamente allagate lungo i grandi fiumi della pianura, o al piede dei versanti dove confluisce l'acqua. Le due piante che crescono in questi terreni ricchi di acqua sono: l'ontano nero, specie arborea principale in queste formazioni ed in grado di sopravvivere anche in ambienti sempre inondati; in condizioni ambientali meno difficili, ma sempre umide e con ristagni, si riesce ad insediare e a crescere rigogliosamente anche l'olmo.
Nel sottobosco si sviluppano diverse specie di arbusti, tra cui il viburno o pallon di maggio, molto appariscente durante la fioritura; a questo si accompagna anche la fragola, soprattutto sui margini del bosco. Anche tra l'erba si hanno delle colorate sorprese: qui vegetano il cardo giallastro, i carici, l'olmaria e anche la valeriana.
Tra le specie di animali che vivono in questi boschi sono quelle legate alle pozze presenti in queste zone: è il caso della Rana di Lateste, una specie diffusa principalmente nella Pianura Padana; poi la salamandra ed il tritone crestato. Tra gli uccelli invece si può trovare la Cincia Bigia e il Martin Pescatore.
L'habitat dei boschi umidi si può trovare lungo il torrente Curone nella parte più alta della valle, a nord della cascina Fornace superiore, oppure a valle di Cascina Valfredda. Se invece si percorre il Molgoretta, è possibile osservare questi boschi ai margini della strada che da Lomaniga porta alla Valle Santa Croce.
MILLE FIORI
Dalla seconda metà degli anni Novanta sono stati condotti diversi censimenti floristici grazie ai quali è stato redatto un elenco che, seppur in continua evoluzione, offre una panoramica sulla consistenza del patrimonio biologico vegetale del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Ad oggi sono censite più di un migliaio di specie tra erbacee e legnose, ma c'è da considerare il fatto che vi sono specie che ogni anno vengono trovate ed altre che scompaiono. Queste variazioni vengono prontamente annotate sul database del Parco, consultabile via Internet.
Fra le presenze floristiche più interessanti e pregiate del Parco ci sono le orchidee, alcune delle quali divenute ormai rare nel nostro territorio. Fra gli ambienti che danno contributo particolare all'elenco di queste rarità spiccano i prati magri nei quali se ne possono trovare ricercate tipologie come la ofride fior d'api che cresce sui terrazzamenti oggi coltivati a vigneti; altrimenti la rarissima ofride insubrica, anch'essa possibile da individuare fra i tralci di vite.
Nei boschi si può trovare anche l'orchidea maggiore, che è la più appariscente del Parco, raggiungendo tra i trenta e gli ottanta centimetri di altezza; nei suoli più umidi e vicino ai corsi d'acqua, c'è poi il gladiolo dei campi ma anche lo zafferano selvatico, entrambi presenti in pochi esemplari.

La maggior parte della flora del parco è comunque costituita da specie comuni e diffuse in tutto il territorio brianzolo, che vegetano nelle radure di robinia. Pur essendo considerate infestanti, queste ultime, esercitano una funzione di conservazione dello strato erbaceo appartenuto alle foreste precedenti. Alcuni di questi fiori comuni, ma altrettanto affascinanti, sono gli anemoni di bosco, le primule comuni o il papavero spinoso.
LA FAUNA AUTOCTONA E REINTRODOTTA
Se molto tempo fa le colline di Montevecchia erano popolate da una grande varietà di animali, oggi, purtroppo, ne sono rimaste solo alcune specie, che tuttavia sono varie e sorprendentemente vitali.
Negli oltre duemilasettecento ettari di territorio protetto diviso tra boschi d'alto fusto, praterie e aree agricole, vivono trenta specie di mammiferi, settantacinque specie di uccelli nidificanti o di passo, nove specie di anfibi, otto di rettili e innumerevoli di invertebrati. Inoltre i torrenti Curone, Lavandaia e Molgoretta ospitano diciassette specie di pesci. È davvero sorprendente trovare tutto questa ricchezza in una delle aree con il tasso di densità abitativa più alto d'Europa.
Tutto questo non significa che l'avvistamento degli animali sia facile; il più delle volte per scorgerli nel loro ambiente naturale sono necessarie pazienza, esperienza e anche un poco di fortuna. Del resto sono proprio queste le ragioni che trasformano in un'emozione indimenticabile gli attimi in cui ci si trova inaspettatamente al cospetto di un animale selvatico.
Il rischio che corre quest'area è la condizione di isolamento ecologico del Parco accerchiato da una cortina edificata che appare difficilmente valicabile dagli animali. Se non vi sono case, si hanno strade e ferrovie a ostacolare gli esigui corridoi ecologici esistenti.

Questa condizione influenza fortemente la presenza degli animali e in particolare dei mammiferi, tant'è che per potenziare o ricostituire alcune popolazioni si è dovuto ricorrere alle reintroduzioni. Infatti l'isolamento impedisce agli animali di accedere e uscire dal Parco, diminuendo radicalmente il loro movimento e gli scambi genetici. La mancanza di questa possibilità rende sempre più vicino il rischio di un incontrovertibile impoverimento della biodiversità.
Da tempo si è compreso questo problema ed il Parco si è sempre impegnato a tutelare gli esistenti habitat, a riqualificare le zone compromesse, ma anche a costituire corridoi e aree di sosta per facilitare la dispersione e la migrazione delle specie.

Fra i trenta mammiferi che popolano il Parco del Curone se ne possono citare tre:
La volpe è il predatore di maggiori dimensioni nel Parco. Solitaria si aggira furtiva nei boschi preferendo le zone caratterizzate da artefatti e rocce che offrono migliori possibilità di rifugio; si ciba di tutto ciò è commestibile, preferendo conigli, scoiattoli e piccoli animali domestici. Data la sua spiccata adattabilità, è possibile vederla in tutto il parco: dagli ambienti forestali dell'alta Valle del Curone, sino alle praterie incolte, ai campi agricoli e addirittura nei pressi dei centri abitati.
La faina trova rifugio nei fienili, sottotetti e case abbandonate o poco frequentate; altrimenti nei boschi si rifugia nelle cavità degli alberi o negli anfratti delle rocce. Ha un corpo allungato, il muso appuntito e orecchie sviluppate; la pelliccia è folta e di colore bruno grigiastro, mentre la gola ed il petto sono coperte da un manto più chiaro. Si nutre prevalentemente di insetti, anfibi, topi e ghiri ed è possibile avvistarla nelle boscaglie e praterie.
La donnola è conosciuta per la sua agilità, infatti è un abile predatore specializzato nella cattura dei piccoli mammiferi, soprattutto topi e arvicole. La sua tecnica di caccia consiste nell'intrufolarsi nelle tane delle sue prede, non lasciando loro via di scampo. Condivide il suo habitat naturale con la faina, per quanto sia diffusa su tutto il Parco.
Tra i mammiferi di più piccola dimensione troviamo i ghiri ed i moscardini; i primi frequentano le soffitte ed i granai, dove dormono durante il giorno, mentre dal crepuscolo iniziano la sua attività alla ricerca di frutta secca e non oppure corteccia che, durante l'autunno, accumulano nelle loro tane per il lungo letargo invernale. Con la loro pelliccia di color grigio o castano sul dorso e bianco-gialla sul ventre sono facili da riconoscere.

Anche il moscardino è un animale notturno, vive nelle macchie più fitte, dove con foglie, muschio e piccole radici costruisce un nido tondo e accogliente; a metà ottobre circa, raccolte le provviste per il letargo, si raggomitola nel suo nascondiglio e si addormenta. Simile ad un topolino, si distingue per il pelo giallo fulvo nella parte superiore compresa la coda, e più chiaro in quello inferiore.
Il Parco si è incaricato di reintrodurre due specie scomparse per la caccia oppure per il sopravvenire di specie infestanti: il tasso e lo scoiattolo rosso.
Il tasso è stato reintrodotto agli inizi del Duemila in seguito alla sua scomparsa a causa della considerazione nociva per l'agricoltura e la leggenda che il suo grasso fosse una cura formidabile contro i reumatismi. Tra il 2000 e il 2008 sono stati liberati otto tassi di cui sono stati seguiti i movimenti da alcuni ricercatori per confermare che si fossero stabiliti nel Parco. Il tasso, per quanto appartenga alla stessa famiglia della donnola e della faina, è più grande di queste, arrivando a pesare fino a 14 chili.
Dall'aspetto tozzo e compatto, ha la testa piatta con dei piccoli occhi e zampe corte; i suoi baffi (vibrisse) e l'olfatto molto sviluppato gli consentono di muoversi bene nel buio delle gallerie che scava, mentre la vista non è il suo forte. Il suo manto bianco con le strisce nere, lo rendono facilmente riconoscibile.

Essendo un eccellente scavatore, realizza dei veri e propri labirinti sotterranei con vari accessi all'esterno. Un fatto molto curioso è che il tasso è in grado di chiudere le orecchie e parte delle narici in modo da non farci entrare polvere e terra mentre scava.
Il problema di avere una casa con tante uscite è che il tasso non è in grado di controllarle tutte; a per questo suo ragionevole limite, altri animali possono approfittare di questa enorme "casa". Fatto curioso è che le tane dei tassi vengono utilizzate nelle generazioni successive, permettendo a questa specie di stabilirsi con più facilità nella stessa zona.
Un'altra reintroduzione avvenuta alla fine del secolo scorso è stata fatta per lo scoiattolo rosso. Questo animale era sempre stato considerato una presenza costante nei boschi, ma fino a pochi anni fa era assente nel Parco del Curone dato lo sfruttamento dei boschi e delle trasformazioni del territorio prima della nascita dell'area protetta. Purtroppo, essendo isolata dal resto delle aree naturali, il ritorno di questa specie non è stato possibile che avvenisse naturalmente.
Lo scoiattolo rosso è un roditore che con i suoi lunghi denti incisivi rosicchia pinoli, bacche e noci, oltre che a bacche e larve di insetti; vive sugli alberi e nei boschi di roverella e castagno del Parco che gli offrono cibo in abbondanza. Il pelo bianco sulla pancia e rosso scuro sul dorso lo rende riconoscibile insieme alla sua folta coda che gli è utile per mantenere l'equilibrio durante le sue corse forsennate sui rami più alti.

Con l'arrivo della stagione fredda lo scoiattolo rosso costruisce il suo nido a forma arrotondata, nascosto nella chioma degli alberi di solito alla diramazione di un grosso ramo dal tronco per poter resistere al vento e alle intemperie. In questi nidi lo scoiattolo rosso trascorre gran parte del suo tempo durante l'inverno; infatti non cade in letargo, ma esce dal nido solo per dissotterrare i semi che ha nascosto ai piedi del suo albero durante l'estate. Molti di questi semi vengono dimenticati dagli scoiattoli che li hanno nascosti, fornendo cibo ad altri animali, oppure permettendo di crescere a nuove piante.
Lo scoiattolo grigio si distingue da quello rosso sia per il colore del suo manto, sia per il fatto che è più aggressivo e disturba l'alimentazione del primo e la sua riproduzione. Le due specie hanno sempre vissuto separatamente (il grigio in America ed il rosso in Europa), ed ora si trovano a dover contendere come rivali lo stesso ambiente.
Ultima specie delle tante che vi sono e di cui vorremmo accennarvi è il gambero di fiume che è altamente tutelato poiché la sua esistenza è considerata vulnerabile. Come tutti i crostacei ha i l corpo rivestito da un esoscheletro (scheletro esterno robusto e solido) di un colore che può variare tra il grigio verdastro ed il bruno scuro, permettendogli di mimetizzarsi sul fondale dei torrenti in cui vive. Questa armatura ne limita lo sviluppo, quindi deve essere periodicamente cambiata: il gambero già a dopo due settimane di vita si sfila la vecchia corazza rimane però indifeso in attesa che si ricostituisca il suo esoscheletro, per tanto rimane immobile e nascosto nella sua tana.
Il gambero di fiume vive nei corsi acqua limpida e ben ossigenati con fondo ciottoloso o fangoso, ma con una corrente lenta o stagnante. Si ciba di chioccioline d'acqua, vermi, girini, larve di insetti e piccoli pesci che trova nel torrente, ma è lui preda di piccoli mammiferi come i topi, oppure pesci o uccelli (come l'airone).
Questo crostaceo è un animale lento, che procede velocemente solo all'indietro, spinto dalla sua coda (chiamata telson) e pertanto non può inseguire le prede; trova rifugio nelle tane che scava sotto i sassi sommersi o gallerie sulle sponde fangose dove trascorre il giorno per uscire all'imbrunire alla ricerca di cibo.
È possibile vedere questo piccolo amico dopo il crepuscolo nei ruscelli che percorrono il Parco, ma ne è severamente vietata la raccolta o il minimo disturbo del loro habitat. Per questo motivo è vietato attraversare i ruscelli a piedi oppure farli attraversare da animali domestici dato che potrebbero involontariamente trasportare dei parassiti nocivi a questi crostacei.

I CORPI VOLONTARI, LE AZIENDE E L'AMMINISTRAZIONE
Parlando ora dell'organizzazione del Parco, è bene comprendere che si tratta di un ente pubblico regionale il cui governo è affidato al Consorzio dei Comuni che ne fanno parte: Cernusco Lombardone, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Sirtori e Viganò.
La responsabilità politica, con compiti prevalentemente di indirizzo, è affidata all'assemblea dei rappresentanti degli enti consorziati, ad un consiglio di amministrazione ed al presidente. L'assemblea definisce l'indirizzo e svolge un controllo politico e amministrativo del consorzio; il consiglio di amministrazione assume i principali atti di gestione tra cui la proposta del bilancio preventivo e consultivo; il presidente è il rappresentante legale e istituzionale dell'ente, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e dell'assemblea.
In occasione della nostra visita al Parco del Curone, siamo stati accompagnati da Marco Molgora, presidente del Parco dal 2019, e Giovanni Zardoni responsabile delle Guardie Ecologiche Volontarie oltre che membro del Gruppo Volontario Antincendio.
Il presidente ci ha raccontato della sua esperienza che ha preso il via da qualche anno alla guida del Parco Regionale, quando è subentrato al predecessore Eugenio Mascheroni. "La descriverei come una felice esperienza che ho accettato a novembre del 2019. Il mio ruolo è affiancato dal consiglio di gestione che riporta gli interessi dei Comuni consorziati, della Provincia di Lecco e della Regione Lombardia. Un organo in cui si cerca e si raggiunge il compromesso e che ritengo competente nel ruolo che svolge ed essenziale per la buona riuscita della gestione del Parco. Il fine ultimo di questo ente è quello di raggiungere l'equilibrio tra il benessere e la tutela della natura, le esigenze delle attività presenti in esso e le necessità di coloro che fruiscono di questo luogo'' ci ha spiegato.
Nell'ultimo periodo l'affluenza presso il Parco è davvero salita alle stelle, soprattutto durante quei brevi periodi in cui era permesso spostarsi dopo il lockdown, come anche nelle giornate più calde degli ultimi due mesi. Molgora ci ha infatti riferito che è davvero un'impresa riuscire a gestire tutte le persone che invadono il Parco, molto spesso senza la minima considerazione del luogo che stanno visitando.

"Uno dei flagelli che colpisce il Parco è il parcheggio selvaggio; per questo motivo già da tempo ci si sta organizzando per limitare l'accesso alle strade che accedono alla zona protetta. Già prima della pandemia avevamo pensato di organizzare un servizio navetta che permettesse ai visitatori di lasciare le auto presso i parcheggi delle vicine stazioni di Olgiate e Cernusco-Merate e raggiungere il Parco. Oggi stiamo pensando anche di introdurre un servizio di bici elettriche a noleggio ed un rispettivo circuito che queste potranno percorrere. È importante sapere che i sentieri hanno necessità di una continua manutenzione, ma quando sono percorsi da biciclette necessitano di una cura e quindi di una spesa, maggiore a causa degli avvallamenti che si creano nei sentieri per il passaggio delle ruote delle bici. Volendo favorire la visita da parte dei ciclisti, come anche degli appassionati di equitazione, abbiamo deciso di progettare dei percorsi ad hoc per queste due categorie di utenti, permettendo loro di visitare il parco in tutta tranquillità" ha proseguito Molgora.
Ulteriore desiderio del presidente è quello di riuscire ad ampliare il territorio dell'ente attraverso la stipula di convenzioni che vedranno riunire sotto il solo nome del Parco della Valle del Curone aree verdi confinanti come la Valle della Nava, oppure le aree verdi di Airuno e di Valgreghentino, sottoponendo anche quelle zone ad una maggiore tutela ambientale.
Il rispetto delle regole e la tutela degli habitat vengono garantite dalle Guardie Ecologiche Volontarie che nell'arco della settimana svolgono svariati turni di controllo per verificare che tutto sia in ordine. Le GEV tivestono anche un importante ruolo nel progetto educativo del Parco che ogni anno ha portato numerose classi dai Comuni limitrofi per riscoprire il contatto con la natura. Queste attività vengono svolte presso Cascina Butto, dove si trova il centro visite con varie attività sensoriali, ma anche a Ca' Soldato, dove si possono osservare esemplari impagliati delle varie specie animali che popolano il Parco.
A causa del Covid queste esperienze sono state sospese durante l'anno scolastico, ma molti centri estivi hanno approfittato dell'organizzazione di visite contingentate presso Cascina Butto per far godere della natura i loro iscritti.
Ogni estate le GEV insieme all'Associazione Monte di Brianza, al CAI di Calco e l'Associazione Volontari Antincendio Boschivi di Olgiate, organizzano un campo di lavoro estivo per compiere importanti attività di manutenzione, come ad esempio lo sfalcio dei campi magri.

Per diventare Guardie Ecologiche Volontarie serve un percorso di formazione e si devono svolgere almeno circa centosettanta ore di servizio all'anno. Entrare a far parte del Gruppo dei Volontari del Parco del Curone, che assiste nello svolgimento delle loro funzioni le GEV, è assai più semplice e meno impegnativo, per quanto prezioso. È infatti sufficiente svolgere un colloquio conoscitivo con il responsabile delle GEV per poi poter iniziare a collaborare alla tutela del Parco. I volontari, insieme alle GEV e ad altre associazioni, si prendono cura dei settanta chilometri di sentieri, rendendoli sicuri e agibili tutto l'anno.
Un ulteriore modo per tutelare l'ambiente è l'iscrizione al Gruppo dei Volontari Antincendio della Protezione Civile che, dietro a Cascina Butto, ha il compito di predisporre una vasca d'acqua utile per rifornire gli elicotteri antincendio. Questo luogo riveste particolare importanza in quanto punto di pescaggio per gli incendi boschivi della parte nord della provincia di Lecco.
Il parco però è anche un luogo in cui le aziende agricole svolgono la loro attività secondo regole specifiche e con impegni concreti. Tutti i prodotti agricoli del parco riportando un marchio di certificazione concesso alle aziende che praticano agricoltura biologica rispettando i protocolli disciplinari aziendali e di produzione. Inoltre gli agricoltori si impegnano a migliorare il paesaggio agrario, ad adottare e incrementare tecniche di buona prassi agricola, ad applicare la rotazione delle colture e a non utilizzare o ridurre l'uso di fertilizzanti chimici e dei diserbanti.
Quindi il marchio "è un prodotto del Parco" certifica la provenienza e la sostenibilità delle produzioni di campo, nonché e la volontà e l'impegno dei produttori che scelgono di salvaguardare e conservare i segni e le tradizioni dei secoli di agricoltura che hanno costruito il paesaggio del Parco del Curone.
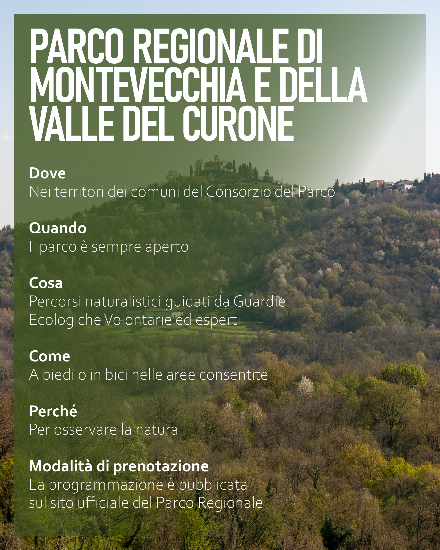
In questo articolo abbiamo cercato di fare l'impossibile, ovvero di riassumere tutte le bellezze che il Parco di Montevecchia e della Valla del Curone raccoglie nei suoi confini. Siamo felici di invitarvi a visitare il Parco ricordandovi ancora una volta di rispettarlo per davvero affinché si mantenga e possa essere apprezzato anche in futuro da tutti.
Vogliamo infine ringraziare il presidente Molgora e il responsabile GEV Giovanni Zardoni per i materiali informativi che ci hanno fornito, tra cui il testo "Parco di Montevecchia e della Valle del Cuirone: Cuore Verde di Brianza" di Michele Mauri.


















