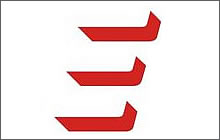Viaggio in Brianza/42: viticoltura, cucina e bachicoltura le tappe della visita al MEAB

LA NASCITA DEL MUSEO E LA SUA MISSIONE
Ideato nel 1983 da parte degli amministratori del Parco del Monte Barro come museo delle attività agricole, è composto da un grande spazio espositivo che per secoli e fino a qualche decennio fa, era occupato da abitazioni e stalle di alcune famiglie di contadini, divenuti nel corso del Novecento operai. Questo spiega l'idea originaria del museo: quella di documentare e studiare la cultura della popolazione rurale, che ha caratterizzato con la sua presenza ed il suo lavoro la Brianza collinare, rappresentata emblematicamente dal borgo di Camporeso e nei suoi dintorni.
Oggi dunque quegli stessi ambienti raccontano i lavori, le tradizioni, le credenze e le forme espressive delle classi popolari del diciannovesimo e ventesimo secolo. Il MEAB nasce e si definisce come un museo etnografico in quanto utilizza nelle sue ricerche il metodo di indagine praticato dall'antropologia: esso consiste nell'incontro tra il ricercatore e il portatore di una cultura differente dalla sua, come quella di contadini, operai, pescatori, cacciatori, filatrici, casalinghe, cuoche che vengono osservati nella loro attività quotidiane e intervistati durante una lunga frequentazione.
Il passato interessa quindi il ricercatore prima e il visitatore del museo poi, perché presenta usi e costumi che si sollecitano a confrontarsi e ad integrarsi per spiegare e comprendere le culture ''altre''. La raccolta di oggetti, interviste e riprese filmate che il museo conserva e presenta è iniziata nel 1998 grazie al coinvolgimento di molte persone che hanno scelto di contribuire in maniera diretta a questo progetto come testimoni e donatori. L'iniziativa è stata di alcuni amministratori, a partire da Giuseppe Panzeri, storico presidente del Parco del Monte Barro che ha sollecitato diversi ricercatori a collaborare nell'impresa. Ciò ha dato vita ad un'esperienza originale, almeno in Lombardia: quella di un parco regionale con vocazione naturalistica che ha investito sulla ricerca e la divulgazione in campo etnoantropologico.
Il MEAB è di fatto un museo del presente perché vive e trova senso nelle testimonianze di chi oggi può raccontare di un passato recente e delle sue trasformazioni, sulla base di esperienze diretta. Ecco perché si presenta come un ''museo delle voci e dei gesti'' dei protagonisti delle attività significative del territorio. Una simile istituzione vuole essere ''museo di società'', non solo perché valorizza il patrimonio culturale diffuso, ma anche perché sollecita la partecipazione attiva di settori significativi della comunità.
Il museo diviene quindi, con la sua missione di educazione permanente, luogo di confronto tra abitudini diverse, luogo di analisi e di riflessione sulla nostra cultura e sulla nostra società complessa, al di là del mito tanto diffuso di un passato idilliaco.
IL BORGO DI CAMPORESO
Il borgo agricolo di Camporeso, con residenza padronale e oratorio settecentesco, si caratterizza come un nucleo a corte chiusa. Attestato all'inizio del Trecento, conserva ancora tracce di quel periodo come un arco falcato ed un finestrone gotico, ma anche dei secoli successivi ricordando le case torri e le case colombere. La casa padronale invece presenta porte finestre con mensola a ringhiera, tipiche dell'esperienza barocchetta.
Il nome Camporeso è da interpretare come ''Campo regio'', cioè terreno demaniale; altra interpretazione derivante dal dialetto della zona Gamboleso (Gambulées) che significherebbe Campo laetus, cioè campo fertile dal latino. Proprietari della porzione più consistente di Camporeso sono stati i nobili Tinelli di Gorla e, per la porzione a monte, l'Ospedale Fatebenefratelli.
È in quest'ultimo edificio, acquisito dal Parco del Monte Barro nel 1991 dall'USSL di Lecco, che è stato realizzato il MEAB. La scelta di questo luogo come sede per il museo si spiega perché Camporeso appare come un luogo emblematico rispetto all'economia, alla società e alla cultura popolare prevalenti, nel lungo periodo, nella Brianza collinare. Il terreno qui, a prezzo di un duro lavoro spesso fatto a mano, era infatti adatto alla coltivazione della vite, ma anche del gelso. Dopo l'arrivo della fillossera nel 1879 ed il successivo innesto dei vitigni americani, nei primi anni del Novecento a Camporeso si producevano venti ettolitri di vino all'anno. Con i tanti gelsi era possibile anche allevare i bachi da seta che, negli anni Trenta del secolo scorso portavano alla produzione di sei o sette quintali di bozzoli. Nel 1901 a Camporeso vivevano novantatré persone; dopo la Seconda guerra mondiale, la crisi dell'agricoltura portò questo luogo e le cascine circostanti ad uno rapido spopolamento.
Oggi il borgo rivive di nuova vita sia per la presenza del MEAB, ma anche perché tra le sue mura è nata un'attività recettiva, un bed & breakfast molto frequentato soprattutto da stranieri che scoprono da questo luogo privilegiato il nostro territorio e le nostre tradizioni.

IL LAVORO NEI CAMPI
La sala più ampia del museo è dedicata all'agricoltura tradizionale: l'attività che per secoli ha garantito il sostentamento della gran parte degli abitanti della Brianza. Gelso per il baco da seta, fieno, mais, frumento, vite sono stati i prodotti principiali delle nostre colline tra Settecento e Novecento.
Fino alla diffusione dell'industria, la produzione agricola ha condizionò le modalità colturali e le tecniche produttive, le forme contrattuali ed il regime di proprietà della terra. Quei prodotti inoltre hanno determinato le condizioni di lavoro, spesso praticato con la sola forza muscolare dei contadini e le condizioni di vita della popolazione. Che fossero di piccoli proprietari o di coloni legati ai padroni della terra da vari contratti, le famiglie contadine furono le protagoniste dell'agricoltura dell'alta Brianza. Nei campi stavano uomini, donne e bambini, secondo un modello che non prevedeva presenza di salariati ma ''metteva al lavoro'' tutta la famiglia.
Dall'Ottocento al Novecento, sono state le famiglie contadine a fornire, prima, la manodopera femminile alle filande e poi quella maschile alle officine. In queste famiglie divenute ''pluriattive'', si delinearono due figure che accompagnarono il crepuscolo dell'agricoltura tradizionale nell'alta Brianza: quella dell'operaio-contadino, lavorante inserito nel nuovo contesto economico ma ancora legato alla terra, e quella dell'ex affittuario che riuscì, nel secondo dopoguerra, a diventare proprietario di piccoli appezzamenti dove portò avanti un'attività divenuta oramai di secondaria importanza. Proprio grazie alle donazioni da parte di queste famiglie è stato possibile costruire una parte importante del patrimonio del museo.
Le macchine d'uso domestico e gli strumenti di lavoro conservati nei solai, nei ripostigli, nelle cantine e nelle cascine, che un tempo servivano alla bachicoltura, alla coltivazione dei campi e della vigna, alla fienagione e all'allevamento, ma anche gli utensili e i manufatti dei lavori artigiani, sono diventati patrimonio con cui documentare la cultura materiale e ricostruire la storia sociale del territorio che sta attorno al museo.

LA BACHICOLTURA: UN LAVORO FATTO IN CASA
All'ingresso del museo si viene accolti in quella che un tempo era la cucina per una delle famiglie che abitavano la cascina; questo spazio tra maggio e giugno, fino almeno agli anni Quaranta del Novecento, veniva destinato all'allevamento del baco da seta. Molti degli oggetti esposti in questa sala provengono dalle famiglie dei lavoranti; le incubatrici invece erano dei maggiori proprietari terrieri, che acquistavano il seme dei bachi dai laboratori specializzati e lo distribuivano per l'allevamento nelle diverse cascine.
Per più di due secoli nel lecchese la bachicoltura ha avuto grande importanza nell'economia e nella vita quotidiana per i contadini ed in particolare per le donne. Queste infatti, oltre ad occuparsi dell'allevamento dei bachi, traevano il filo di seta dai bozzoli nelle filande dove, le giornate interminabili erano alleggerite dal canto collettivo, che in alcuni casi esprimeva la protesta delle operaie.

Il baco si nutre esclusivamente della foglia del gelso, pianta che copriva gran parte delle colline e dell'alta pianura, ciò non favoriva i prodotti del suolo circostante, ma, come ci ricorda Stefano Jacini, studioso di agricoltura e senatore dell'Italia unita, il proverbio diceva che "l'ombra del gelso è l'ombra d'oro". Con un lavoro molto impegnativo, i contadini cercavano di procurarsi con l'allevamento del baco, un'importantissima entrata in contanti dopo le ristrettezze delle stagioni invernali a condizione che non intervenissero le malattie del gelso e del baco. Nelle case coloniche i locali impiegati per la bachicoltura erano in primo luogo la cucina, ma anche altre stanze dotate di camino, questo perché per allevare i bachi era necessario che il locale rimanesse intorno alla temperatura di ventitré gradi. In queste stanze si montavano le tavole a graticcio fatte di canne su cui si alimentavano i bachi con le foglie di gelso. Quando i bozzoli erano pronti, venivano trasportati ad una filanda o all'ammasso poi venderli a degli intermediari. Nella speranza di avere un buon raccolto di bozzoli si seguivano consigli tecnici, ma più spesso ci si affidava a pratiche devozionali. I ragazzi passavano di casa in casa a cantare il cristée per propiziare l'imminente attività di allevamento e soprattutto si pregavano la Madonna e il beato Giobbe, rappresentati insieme suaffreschi p quadri in moltissime case coloniche; il beato, eletto a patrono della bachicoltura, è facile da riconoscere perché i pittori popolari lo rappresentano con i bachi che escono dalle sue piaghe.
Dalla seconda metà dell'Ottocento la produzione subì varie inflessioni anche per la concorrenza straniera, fino allo smantellamento massiccio delle filande dopo il 1930 e alla loro chiusura definitiva negli anni Cinquanta del secolo scorso.

LA VITICOLTURA
Con le donazioni di molte famiglie il museo ha acquisito oggetti e strumenti utilizzati, fino ad anni relativamente recenti, nella vigna o in cantina. Due quindi sono le sezioni e gli spazi dedicati a questa produzione che viene documentata anche attraverso le immagini, interviste e filmati realizzati negli ultimi anni.
La Brianza ha una vocazione vitivinicola molto antica. In passato i vini prodotti nella nostra regione erano estremamente apprezzati, valgano per tutti i giudizi entusiastici che ne dava nei suoi versi Carlo Porta. A partire dalla metà dell'Ottocento una serie di calamità dovute a malattie giunte dall'America, si abbatté sulla viticoltura brianzola, come su quelle di tutta Europa: dapprima l'Oidio che, a partire da 1850, causò un gravissimo tracollo della popolazione. Scoperta l'azione repellente dello zolfo contro questo parassita, fu possibile superare questa prima crisi del settore. Successivamente a fine anni Settanta comparve la peronospora, un fungo parassita che provoca la morte della vite. Infine la gravissima crisi provocata dalla diffusione della fillossera che fu superata grazie al ricorso ai vitigni americani, dimostratisi resistenti al parassita. Fu così possibile da un lato coltivare i frutti di oltre oceano, ma anche salvare le antiche varietà europee, assai più pregiate, innestandole su vitigni americani.

Già nell'Ottocento tra i primi vitigni diretti ad essere importati fu il Clinton (localmente detto clinto), tutt'ora diffusissimo. Oggi solo nei comuni intorno alla collina di Montevecchia si produci vino secondo gli standard moderni con un'attività economica specializzata. D'altra parte, la piccola viticoltura praticata a livello familiare più per ragioni sentimentali che economiche ha conservato per vari aspetti, metodi colturali che possiamo definire arcaici: ciò costituisce un particolare motivo di interesse in una prospettiva etnografica.
Il museo con la documentazione e i numerosi oggetti raccolti, fornisce una indiretta manifestazione della presenza e della diffusione di questa attività, che dava una risorsa importante per l'alimentazione e anche per la medicina popolare secondo le credenze compendiate nel proverbio: "Il vino fa sangue, l'acqua fa tremare le gambe''.

LA CUCINA TRADIZIONALE
Nel museo è ricreata una vecchia cucina che, almeno in ambiente popolare, era considerata il locale più importante della casa. Attorno al focolare, e più tardi alla stufa, c'era più calore, lì si cucinava e le donne insieme ai bambini passavano la maggior parte del tempo, soprattutto nei periodi invernali.
In questo spazio sono stati collocati molti e diversi strumenti per la preparazione dei cibi, per la cottura degli alimenti, per il consumo delle pietanze e delle bevande, la conservazione degli avanzi e pochi mobili per i bisogni degli adulti e dei bambini. L'allestimento interattivo propone anche numerose interviste sui principali alimenti, sui piatti più diffusi, su ciò che si mangiava nei diversi momenti della giornata e nelle varie stagioni o in occasione delle feste. Si possono anche ascoltare fiabe o novelle e canti, registrati in Brianza, che parlano di cibi bevande e delle occasioni in cui si consumavano.
In molte famiglie le necessità quotidiane del lavoro impedivano spesso che si mangiasse insieme o al tavolo; si faceva colazione in campagna o dove si stava lavorando, ad esempio per la fienagione e per il taglio dei boschi. Quando poi il tempo lo permetteva, nelle case delle famiglie numerose il pasto principale si consumava all'aperto, sotto i portici o nel cortile. Le osterie, le trattorie, i ristoranti erano luoghi di ritrovo per gli uomini nei giorni festivi, per i coscritti, prima del servizio militare, oppure per le famiglie in particolari occasioni come i matrimoni.
Fino agli anni Cinquanta l'alimentazione popolare nelle campagne era basata sui prodotti locali di origine vegetale (erano immancabili la polenta e le minestre) integrati dalla carne di maiale allevato in gran parte delle case contadine e più raramente dalla carne di altri animali: tutto dipendeva condizione e delle proprietà della famiglia.
Osservando questa sala del museo e le interviste multimediali ci rendiamo conto di come sia mutato radicalmente il nostro stile di vita ed il rapporto con il cibo. Un tempo i campi lavorati con fatica erano l'unica fonte da cui si poteva trarre lo stretto necessario per la propria sopravvivenza.

LA STALLA: DOVE SI LAVORA E SI IMPARA
Nella società tradizionale la stalla era, con la cucina, il luogo più importante della casa contadina; essa era infatti destinata alla custodia degli animali come bovini ed equini in particolare nelle ore notturne e nel periodo invernale, ma anche al ritrovo delle persone, alla comunicazione tra le generazioni e i sessi, all'educazione dei bambini, alla trasmissione di credenze e di comportamenti prescritti mediante i racconti, l'esempio e la recita di preghiere.
Nelle ore serali e nella stagione fredda era inoltre un luogo dove si svolgevano alcuni lavori artigianali, sia da parte delle donne che degli uomini. L'odore di letame che si sentiva nella stalla era ben accetto dai contadini perché testimoniava la presenza di animali, un tempo indispensabili nell'economia familiare, sia per il traporto, sia per la produzione di alimenti come latte, burro e formaggi freschi (oltre agli insaccati di maiale), ma anche per il prezioso ricavo che poteva venire dalla vendita del vitello. Questo infatti era allevato con l'unico fine di essere venduto alle famiglie benestanti dato che la sua carne era molto morbida data la sua alimentazione esclusivamente a base di latte.

L'allevamento bovino era di carattere familiare, con stalle piccole che ospitavano due o tre bestie grosse, in proporzione alla disponibilità di formaggio ed alla forza lavoro su cui poteva contare la famiglia contadina. Gli animali, comprese le pecore che davano la lana, erano dunque un bene molto prezioso, perciò li si affidava alla protezione di sant'Antonio Abate, una figura che i pittori rappresentavano accanto al maiale, ma anche vicino ad altri animali domestici per renderlo maggiormente riconoscibile negli affreschi amatoriali realizzati sulle porte delle stalle oppure, più raramente, al loro interno.
Fino alla metà del Novecento, nei mesi invernali, si passavano le sere e parte del giorno nella stalla. I vecchi raccontavano ai bambini e agli adulti quello che era successo, storie vere ma anche storielle comiche, favole magiche e leggende. I bambini erano molto attratti dai fatti straordinari, spesso spaventosi, che parlavano di esseri mostruosi di morti, di demoni. Oppure un bravo lettore leggeva a voce alta almanacchi o libri che raccontavano storie avventurose o drammatiche. Le donne recitavano il rosario e le litanie invitavano tutti a pregare mentre filavano o lavoravano la lana. Gli uomini invece preparavano attrezzi e oggetti di uso quotidiano che sarebbero serviti per tutto l'anno: scope di saggina, rastrelli, manici per vari utensili, zoccoli, sedie impagliate o scale.

LE ATTIVITA' DEL MUSEO
Oltre alle approfondite visite guidate, il Museo etnografico dell'Alta Brianza propone progetti didattici per scolaresche ed oratori in cui far confrontare le nuove generazioni con gli usi di un tempo. Per fare questo vengono organizzate delle mostre temporanee e una rassegna intitolata "Voci, gesti, culture: tra locale e globale" che annualmente raccoglie degli incontri in cui valorizzare la complessità e le differenze culturali ma anche le relazioni, i contatti e gli scambi tra diverse società che producono innovazioni ed integrazioni tra pratiche, costumi, e visioni del mondo. Per la loro realizzazione è decisivo l'impegno del direttore del museo Massimo Pirovano importante ricercatore a livello nazionale, che si occupa del coordinamento delle diverse attività di ricerca. Altrettanto importante è la passione dei tanti volontari e volontarie che donano il loro tempo a questo museo gestendolo in ogni suo aspetto: l'apertura del museo al pubblico, l'organizzazione delle visite guidate e la promozione delle proposte formative del MEAB. Noi abbiamo avuto il piacere di conoscerne due durante la nostra visita: Angela Pennati e Francesca Butti (laureata in antropologia). Durante la nostra permanenza nel museo ci è sembrato di fare un vero salto nel tempo grazie alle loro parole che ci hanno aiutati a comprendere fino in fondo com'era la vita in questo territorio e come si è evoluta.

Vi invitiamo a visitare questo museo: sarà senza dubbio un'occasione per compiere un tuffo nel passato che vi porterà automaticamente a riflettere sui cambiamenti avvenuti per coglierne le positività senza sottovalutarne gli aspetti critici e problematici che ogni mutamento porta con sé. Appuntamento dunque, alla prossima puntata del nostro Viaggio in Brianza, ma se volete continuare a conoscere questa terra ricordatevi di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook.