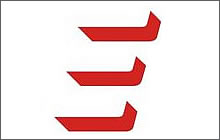RACCONTI DALLA VILLA/11: dal professor Zumbo un omaggio alla Sicilia (con la nota di Ivano Sala)
Siamo al penultimo appuntamento della rubrica Racconti dalla Villa (recuperate l’introduzione QUI e i primi dieci racconti QUI). Presentiamo oggi un dono che ci ha fatto Lorenzo Zumbo, già docente di lettere del Greppi nonché inventore e animatore del premio di narrativa Livia Dean, da cui ci sono venuti tutti i precedenti racconti.
«Cunti» (racconti) è il titolo di questo racconto che Zumbo, scrittore oltre che docente, ha estratto dal nuovo libro cui sta lavorando.
Il testo è accompagnato dalla nota di Ivano Sala, che ha speso la sua carriera di docente al Greppi, ricoprendo per anni il ruolo di vicepreside dell’Istituto dove studiano o hanno studiato gli autori delle storie qui raccolte. Come ogni martedì: lasciatevi trasportare dalla narrazione.
 CUNTI - LORENZO ZUMBO
CUNTI - LORENZO ZUMBO
A Tonnarella c’era un cuntu per ogni crepa, per ogni carcassa di barca, per ogni notte passata in bianco, per ogni agonia.
I cunti si tenevano a stagionare nelle giare, sui graticci, nelle anfore devozionali. Li si sentiva maturare col passare dei giorni, gonfiarsi di vene scure. C’erano cunti che si esaurivano in poche battute. Altri che duravano settimane e che avevano dentro come un rumore di eliche.
Una matassa di cunti avvolgeva il paese, lo sottraeva agli obblighi della geografia. E in effetti i cunti, allora, erano fili di lana, di cotone, di lino, fili d’erba, di saliva. Bastava imbastirne uno, e l’isola diventava un gioco di nomi inventati. Sebastiana a’ sarbaggia, conosciuta in paese come a’ maiara, diceva che quando si cunta si cammina nelle parole senza sapere mai dove si arriva. Un cuntu è una preghiera, mani che si stringono prima di un addio, è pianto, attesa.
Sebastiana a’ sarbaggia, conosciuta in paese come a’ maiara, diceva che quando si cunta si cammina nelle parole senza sapere mai dove si arriva. Un cuntu è una preghiera, mani che si stringono prima di un addio, è pianto, attesa.
Sebastiana a’ sarbaggia viveva in una casupola a ridosso degli ultimi vigneti, prima del viottolo che sale verso Furnari. Era capace di togliere il malocchio, guarire dal mal di luna.
C’erano sere in cui sussurrava nenie dolcissime alle pietre dei torrenti. Allora si scioglieva i capelli, indossava una lunga veste nera, teneva in mano una foglia di limone.
Quando si metteva a cuntari, invece, i suoi occhi brillavano di una luce ambigua, il suo corpo si faceva più flessuoso, le cosce bianche come un lampo. Sebastiana a’ sarbaggia conosceva la pazzia del mare.
Ripeteva spesso un cuntu che mi affascinava, non tanto per il suo svolgimento, che ora non ricordo più, quanto per l’attacco iniziale. Era la storia di uno che era nato il 23 gennaio del 1957. Quel giorno pioveva così tanto che il mare e le strade si erano ridotte a una nebbia biancastra. Forse era un lunedì, forse un venerdì. Ma questo, diceva, aveva poca importanza. La pioggia quel giorno aveva fatto sparire la piazza, gli alberi, gli scogli, l’isola, il mondo. Ogni nascita, qui, è come una cancellazione, aggiungeva Sebastiana a’ sarbaggia, regala un destino di mari capovolti, di acque stregate. A quel punto io la interrompevo e le chiedevo di ricominciare daccapo.
A Tonnarella, allora, c’erano più narratrici che narratori. Io le ricordo come donne alte, dotate di una speciale forma di leggerezza. Lungo le strade del paese si muovevano come chi è in grado di abitare molti posti contemporaneamente. I loro volti avevano una bellezza austera. Lo sguardo sembrava aver rubato all’isola uno dei suoi tanti segreti.
Le narratrici della mia infanzia conoscevano il momento in cui gli angeli della notte entravano nelle case per spargere nel sonno delle donne semi celesti, vincere la sterilità.
In paese si diceva che sotto le loro gonne si trovava il fluido mistero del mondo. E io pensavo che i cunti loro li facevano arrivare proprio da lì.
Le storie d’amore erano le più apprezzate. Ogni storia proveniva da luoghi dove agavi sonnolente fiorivano di colpo e bisognava familiarizzare con l’incipit di quei poemi di follie e seduzioni che cominciano sempre con lo stesso verso: solo tu mi piaci.
Raccontare storie d’amore richiedeva coraggio, disciplina, resistenza fisica. Era un po’ come seguire stradine tortuose che a volte sbucavano in uno spiazzo abbandonato da tutti. C’erano cunti che parlavano di innamoramenti intensi e veloci, altri di innamoramenti che si consumavano lentamente nella grande stagnazione dell’estate.
Chi amava aveva così tante cose da dire che restava muto per mesi. C’erano amanti che, dopo un ultimo commiato, si perdevano lungo balze deserte, valloni fino a lambire fiumi dal corso breve e favoloso: l’Anapo, il Cassibile, il Tellaro. Ogni tanto si fermavano per specchiarsi nelle loro acque e capire che quel volto che ora vedevano non era più il proprio ma quello di un altro che nessuno più conosceva.
Mi affascinava la storia di Ahmed, un marinaio algerino che si consumava d’amore per la polena di una nave a forma di donna dal corpo slanciato, i seni pieni. Ma anche i racconti in cui ci si invaghiva delle isole mi piacevano. Per un mese mi innamorai di una bambina dai capelli corvini che in un cuntu raccoglieva giocattoli rotti e li metteva in grandi scatole di cartone. Erano braccia di bambole, macchinine a cui mancava una ruota, pezzi di calamite, vecchi bottoni di vetro, biglie. In quelle scatole questi resti di giocattoli un po’ guarivano, un po’ sognavano.
Nei pressi della vigna di Nascaredda si trovava il vecchio muro di un edificio distrutto da un terremoto anni prima che io nascessi. Era, probabilmente, ciò che restava di una sconsacrata chiesa di campagna. Un muro piuttosto alto, costellato di crepe, da cui
spuntavano arbusti di capperi. Proprio lì intorno, Sebastiana a’ sarbaggia raccoglieva ciuffi di borragine, finocchietto selvatico, aglio angolare, porcellana comune. Erbe che si erano imbevute del sangue mestruale della luna. A casa le pestava in un mortaio in pietra per ottenere un succo amaro che teneva in piccole ciotole di terracotta. In paese si era convinti che proprio quel succo le permettesse di inventare cunti per chi malediceva Dio per la nostra esistenza finita, per chi aveva perso un figlio.
C’erano notti a Tonnarella in cui nessuno riusciva a dormire. Le cause per cui si verificava questo fenomeno erano oscure a tutti. Alcuni lo collegavano al passaggio delle orche al largo, altri al fiato funebre dello scirocco. Allora si chiedeva a Sebastiana a’
sarbaggia di riempire di cunti il vuoto di quelle notti lunghissime. Così Sebastiana a’ sarbaggia passava di casa in casa come una che giungeva da un altro mondo. Chi l’ascoltava, vedeva scorrere davanti ai suoi occhi tappeti volanti e teste decollate, fiori
carnivori, una donna che si conficcava la spada sette volte nel seno e, cosa ancora più straordinaria, un cuore che si svuotava goccia a goccia di tutto il suo sangue.
Si restava affascinati quando muoveva le braccia, o restava immobile a lungo in piedi, quasi a fare da perno tra cielo e terra. I cunti di Sebastiana a’ sarbaggia non regalavano il sonno ma li si poteva seguire come si segue la scia di una nave che si perde nell’immensità del mare.
A me piaceva la sua voce che trasformava il mondo in un gioco tragico e comprensibile, spietato e mortalmente amico.
Comunque ai cunti, a Tonnarella, bisognava prestare attenzione, perché in un cuntu ci potevano stare questioni grosse come la paura della morte, il sesso, la violenza, il sacro.
Un cuntu poteva lasciarti senza fiato, o poteva anche ridartelo, il fiato, se eri moribondo.
Sebastiana a’ sarbaggia ripeteva che i cunti sono come lo zucchero per i bambini. E lo zucchero, in quest’isola, è sempre violento.
NOTA
Pare di vederlo Lorenzo Zumbo raccontare il suo “cunto”.
Davanti alla porta di casa sua, a Tonnarella, quando la canicola estiva ti invoglia a restare fuori, in compagnia della luna e delle stelle.
Pare di sentirla la sua lingua, il suo dialetto, sangue, saliva, zucchero, borragine e finocchietto selvatico. E di ascoltare il suo “cunto” come fosse un racconto epico-cavalleresco, accompagnato da una mimica e una gestualità d’altri tempi (e per questo
moderno, ferocemente vivo).
E pare di vederla passare Sebastiana a’sarbaggia, novella e antica Sherazade, con il suo profumo speziato, la sua veste nera e la foglia di limone in mano. E subito pare di esser lì, tra la Sicilia, il Mediterraneo e il mare e il sole.
Lorenzo Zumbo ha questo potere di prenderti e portarti con sé, sul suo tappeto volante, carico di odori e sapori forti. O in una casupola, davanti a un camino acceso in una sera invernale. O al fresco in un crepuscolo estivo, con il profumo di zagare tra le
pieghe del corpo.
Abbandonarsi a Lorenzo e alle sue parole regala un momento di sospensione dal tempo.
Che poi è ciò che davvero conta.
LE PUNTATE PRECEDENTI:
-Racconti dalla Villa/0: L'Introduzione
-Racconti dalla Villa/1: Il Diluvio
-Racconti dalla Villa/2: Arlene di Piombo
-Racconti dalla Villa/3: Una mattina come tante
-Racconti dalla Villa/4: L'ombra sulla collina
-Racconti dalla Villa/5: Memorie di un gatto
-Racconti dalla Villa/6: Linee incidenti
-Racconti dalla Villa/7: Una questione sinistra
-Racconti dalla Villa/8: Rifiorire
-Racconti dalla Villa/9: Basta un raggio di sole
-Racconti dalla Villa/10: Guerre
«Cunti» (racconti) è il titolo di questo racconto che Zumbo, scrittore oltre che docente, ha estratto dal nuovo libro cui sta lavorando.
Il testo è accompagnato dalla nota di Ivano Sala, che ha speso la sua carriera di docente al Greppi, ricoprendo per anni il ruolo di vicepreside dell’Istituto dove studiano o hanno studiato gli autori delle storie qui raccolte. Come ogni martedì: lasciatevi trasportare dalla narrazione.
I curatori: Giulia Redaelli e Beniamino Valeriano

A Tonnarella c’era un cuntu per ogni crepa, per ogni carcassa di barca, per ogni notte passata in bianco, per ogni agonia.
I cunti si tenevano a stagionare nelle giare, sui graticci, nelle anfore devozionali. Li si sentiva maturare col passare dei giorni, gonfiarsi di vene scure. C’erano cunti che si esaurivano in poche battute. Altri che duravano settimane e che avevano dentro come un rumore di eliche.
Una matassa di cunti avvolgeva il paese, lo sottraeva agli obblighi della geografia. E in effetti i cunti, allora, erano fili di lana, di cotone, di lino, fili d’erba, di saliva. Bastava imbastirne uno, e l’isola diventava un gioco di nomi inventati.

Sebastiana a’ sarbaggia viveva in una casupola a ridosso degli ultimi vigneti, prima del viottolo che sale verso Furnari. Era capace di togliere il malocchio, guarire dal mal di luna.
C’erano sere in cui sussurrava nenie dolcissime alle pietre dei torrenti. Allora si scioglieva i capelli, indossava una lunga veste nera, teneva in mano una foglia di limone.
Quando si metteva a cuntari, invece, i suoi occhi brillavano di una luce ambigua, il suo corpo si faceva più flessuoso, le cosce bianche come un lampo. Sebastiana a’ sarbaggia conosceva la pazzia del mare.
Ripeteva spesso un cuntu che mi affascinava, non tanto per il suo svolgimento, che ora non ricordo più, quanto per l’attacco iniziale. Era la storia di uno che era nato il 23 gennaio del 1957. Quel giorno pioveva così tanto che il mare e le strade si erano ridotte a una nebbia biancastra. Forse era un lunedì, forse un venerdì. Ma questo, diceva, aveva poca importanza. La pioggia quel giorno aveva fatto sparire la piazza, gli alberi, gli scogli, l’isola, il mondo. Ogni nascita, qui, è come una cancellazione, aggiungeva Sebastiana a’ sarbaggia, regala un destino di mari capovolti, di acque stregate. A quel punto io la interrompevo e le chiedevo di ricominciare daccapo.
A Tonnarella, allora, c’erano più narratrici che narratori. Io le ricordo come donne alte, dotate di una speciale forma di leggerezza. Lungo le strade del paese si muovevano come chi è in grado di abitare molti posti contemporaneamente. I loro volti avevano una bellezza austera. Lo sguardo sembrava aver rubato all’isola uno dei suoi tanti segreti.
Le narratrici della mia infanzia conoscevano il momento in cui gli angeli della notte entravano nelle case per spargere nel sonno delle donne semi celesti, vincere la sterilità.
In paese si diceva che sotto le loro gonne si trovava il fluido mistero del mondo. E io pensavo che i cunti loro li facevano arrivare proprio da lì.
Le storie d’amore erano le più apprezzate. Ogni storia proveniva da luoghi dove agavi sonnolente fiorivano di colpo e bisognava familiarizzare con l’incipit di quei poemi di follie e seduzioni che cominciano sempre con lo stesso verso: solo tu mi piaci.
Raccontare storie d’amore richiedeva coraggio, disciplina, resistenza fisica. Era un po’ come seguire stradine tortuose che a volte sbucavano in uno spiazzo abbandonato da tutti. C’erano cunti che parlavano di innamoramenti intensi e veloci, altri di innamoramenti che si consumavano lentamente nella grande stagnazione dell’estate.
Chi amava aveva così tante cose da dire che restava muto per mesi. C’erano amanti che, dopo un ultimo commiato, si perdevano lungo balze deserte, valloni fino a lambire fiumi dal corso breve e favoloso: l’Anapo, il Cassibile, il Tellaro. Ogni tanto si fermavano per specchiarsi nelle loro acque e capire che quel volto che ora vedevano non era più il proprio ma quello di un altro che nessuno più conosceva.
Mi affascinava la storia di Ahmed, un marinaio algerino che si consumava d’amore per la polena di una nave a forma di donna dal corpo slanciato, i seni pieni. Ma anche i racconti in cui ci si invaghiva delle isole mi piacevano. Per un mese mi innamorai di una bambina dai capelli corvini che in un cuntu raccoglieva giocattoli rotti e li metteva in grandi scatole di cartone. Erano braccia di bambole, macchinine a cui mancava una ruota, pezzi di calamite, vecchi bottoni di vetro, biglie. In quelle scatole questi resti di giocattoli un po’ guarivano, un po’ sognavano.
Nei pressi della vigna di Nascaredda si trovava il vecchio muro di un edificio distrutto da un terremoto anni prima che io nascessi. Era, probabilmente, ciò che restava di una sconsacrata chiesa di campagna. Un muro piuttosto alto, costellato di crepe, da cui
spuntavano arbusti di capperi. Proprio lì intorno, Sebastiana a’ sarbaggia raccoglieva ciuffi di borragine, finocchietto selvatico, aglio angolare, porcellana comune. Erbe che si erano imbevute del sangue mestruale della luna. A casa le pestava in un mortaio in pietra per ottenere un succo amaro che teneva in piccole ciotole di terracotta. In paese si era convinti che proprio quel succo le permettesse di inventare cunti per chi malediceva Dio per la nostra esistenza finita, per chi aveva perso un figlio.
C’erano notti a Tonnarella in cui nessuno riusciva a dormire. Le cause per cui si verificava questo fenomeno erano oscure a tutti. Alcuni lo collegavano al passaggio delle orche al largo, altri al fiato funebre dello scirocco. Allora si chiedeva a Sebastiana a’
sarbaggia di riempire di cunti il vuoto di quelle notti lunghissime. Così Sebastiana a’ sarbaggia passava di casa in casa come una che giungeva da un altro mondo. Chi l’ascoltava, vedeva scorrere davanti ai suoi occhi tappeti volanti e teste decollate, fiori
carnivori, una donna che si conficcava la spada sette volte nel seno e, cosa ancora più straordinaria, un cuore che si svuotava goccia a goccia di tutto il suo sangue.
Si restava affascinati quando muoveva le braccia, o restava immobile a lungo in piedi, quasi a fare da perno tra cielo e terra. I cunti di Sebastiana a’ sarbaggia non regalavano il sonno ma li si poteva seguire come si segue la scia di una nave che si perde nell’immensità del mare.
A me piaceva la sua voce che trasformava il mondo in un gioco tragico e comprensibile, spietato e mortalmente amico.
Comunque ai cunti, a Tonnarella, bisognava prestare attenzione, perché in un cuntu ci potevano stare questioni grosse come la paura della morte, il sesso, la violenza, il sacro.
Un cuntu poteva lasciarti senza fiato, o poteva anche ridartelo, il fiato, se eri moribondo.
Sebastiana a’ sarbaggia ripeteva che i cunti sono come lo zucchero per i bambini. E lo zucchero, in quest’isola, è sempre violento.
NOTA
Pare di vederlo Lorenzo Zumbo raccontare il suo “cunto”.
Davanti alla porta di casa sua, a Tonnarella, quando la canicola estiva ti invoglia a restare fuori, in compagnia della luna e delle stelle.
Pare di sentirla la sua lingua, il suo dialetto, sangue, saliva, zucchero, borragine e finocchietto selvatico. E di ascoltare il suo “cunto” come fosse un racconto epico-cavalleresco, accompagnato da una mimica e una gestualità d’altri tempi (e per questo
moderno, ferocemente vivo).
E pare di vederla passare Sebastiana a’sarbaggia, novella e antica Sherazade, con il suo profumo speziato, la sua veste nera e la foglia di limone in mano. E subito pare di esser lì, tra la Sicilia, il Mediterraneo e il mare e il sole.
Lorenzo Zumbo ha questo potere di prenderti e portarti con sé, sul suo tappeto volante, carico di odori e sapori forti. O in una casupola, davanti a un camino acceso in una sera invernale. O al fresco in un crepuscolo estivo, con il profumo di zagare tra le
pieghe del corpo.
Abbandonarsi a Lorenzo e alle sue parole regala un momento di sospensione dal tempo.
Che poi è ciò che davvero conta.
Ivano Sala
Per visualizzare la versione del racconto in PDF clicca QUI
LE PUNTATE PRECEDENTI:
-Racconti dalla Villa/0: L'Introduzione
-Racconti dalla Villa/1: Il Diluvio
-Racconti dalla Villa/2: Arlene di Piombo
-Racconti dalla Villa/3: Una mattina come tante
-Racconti dalla Villa/4: L'ombra sulla collina
-Racconti dalla Villa/5: Memorie di un gatto
-Racconti dalla Villa/6: Linee incidenti
-Racconti dalla Villa/7: Una questione sinistra
-Racconti dalla Villa/8: Rifiorire
-Racconti dalla Villa/9: Basta un raggio di sole
-Racconti dalla Villa/10: Guerre